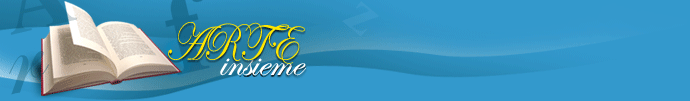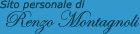Un posto all’ombra Ein Platz im Schattel, di Emilio Paolo Taormina, edito da Giuliano Ladolfi e prefato da Gianfranco Perriera
Un posto all'ombra Ein Platz im Schattel – Emilio Paolo Taormina – Giuliano Ladolfi– Pagg. 110 – ISBN 9788866447689 – Euro 12,00
Prefazione di Gianfranco Perriera
Emilio Paolo Taormina ha un dono, la capacità di animare la sospensione. L'immagine dei suoi versi è sempre icastica – con forti referenze naturalistico /
quotidiane – e insieme tenerissima nella sua delicatezza che si concentra nella brevità. Un sussulto freme sempre al suo interno, la nostalgia del suo stesso provare a durare, la vocazione a richiamare alla presenza, all'appariscenza, chi e quanto, invece, corre il rischio di sfumare nell'assenza, nella sparizione.
Nel luogo dove si scampa al tumulto, nello spazio dove si attende ospitati da una macchia di buio, all'ombra, come dice il titolo di questa nuova raccolta, si è adesso posto il poeta. Quasi volendo smentire il Montale che in Ossi di seppia invitava (e si invitava) a non rifugiarsi nell'ombra e a guardare le forme della vita che si sgretola. All'ombra, al soffuso lucore della sera Taormina ritorna, come un guerriero dopo tante battaglie, come un artista preoccupato di
un'epoca che pare accecata e infuriata dalla perenne luce che su tutti gli schermi e su tutte le vie infiamma il rancore e il rumore. Ma dall'ombra non
smette di guardare al mondo che va in frantumi. Sono stanco / – scrive nel secondo componimento, rivolgendosi a un tu che pare eccessivamente distratto
o dimentico – ti ho chiamata tante volte / che quando ripeto il tuo nome / le stelle si voltano. Tornano spesso le stelle a punteggiare il cielo notturno. Anche quando i galli hanno il canto strozzato in gola – come possono i poeti cantare sotto le bombe e dopo Auschwitz, avevano detto già Quasimodo e Adorno – una stella s'accende sulla collina, ad accompagnare la nascita di Gesù (una caverna illuminata / a Betlemme è nato Gesù). Anche in un tempo di passioni tristi e di efferata violenza, quale si rivela il nostro, il poeta non rinuncia a rintracciare accenni che alludano ad una possibile rinascita, ad una più gentile resipiscenza degli umani. Già Arendt, in effetti, ricordava che il fenomeno della natalità, un bambino nato per noi, potesse essere il segno, il miracolo, di un'umanità che non cede alla rovina e alla iattura. La luna mostra una bocca sdentata – si legge nei versi di Taormina – una vecchiezza, dunque, disfatta – che, come insegnava Leopardi, è simbolo di epoche prive di slanci e speranze, incattivite ed incupite nel loro cinismo – campeggia nel buio; ma due luci si accendono (una stella in alto e un bagliore nella caverna di Betlemme) a punteggiare un possibile appello alla rinascita. La legge morale in noi e il cielo stellato sopra di noi, Kant suggeriva quali vettori di umani non rassegnati al male. Nel cielo di Taormina il vibrare di luci (stelle notturne o l'aurora che è un'arancia e colora l'acquasantiera del mare) sono tracce, iridescenti, che bucano la plumbea accidia degli umani e che avvertono del loro pericoloso deliquio. È così che mentre l'aurora cerca nelle sue viscere la parola / che fa tremare l'anima / le gocce di pioggia esplodono / sul vetro del giorno come un big / bang del mondo in guerra. Il dettato di un nuovo cominciamento, l'inaugurale fare del poeta non può ignorare i disagi e le ferite del mondo. L'ombra non è dunque il buen retiro, dove ci si apparta dal frastuono del mondo, dediti ad un quieto pensionamento. L'ombra, l'imbrunire della sera, il notturno della volta appena trapunta di stelle sono il luogo della riflessione e della rammemorazione. Ciò da cui ci si allontana ricade nell'oscurità, ha scritto Hans-Georg Gadamer. Porsi almeno sulla soglia, sulla proiezione oscura che i corpi derivano dall'opposizione alla luce, pare suggerirci Taormina, è il modo per non abbandonare all'evanescenza le più intense esperienze e le più delicate speranze degli umani. L'ombra, in cui il poeta si pone, salva, perciò, in qualche modo, la stessa possibilità della scrittura poetica in un tempo che si fa afasico e imbruttito. Un libro / – può perciò scrivere – che hai amato / lo riconosci / anche al buio / tocchi il dorso / sfogli le pagine / le carezzi / come il volto / della tua donna. Versi brevi, che rendono quasi sincopata l'azione che si racconta avvenire al buio e la cura, anzi l'amore che si fa tatto come la carezza sul corpo, per le pagine che conservano parole e pensieri. La parola salvata – La lingua salvata è un importante libro di memorie d'infanzia di Canetti, in cui lo scrittore affermava che sentiva ogni parola come fosse stata fatta per l'eternità – conosce i faticosi, impervi, sofferti viaggi che una vita deve saper affrontare per raggiungere il nitore profondo del verso. Pertanto è lungo ed aspro il cammino / che porta la parola / dalla tempesta del sangue / al verso. Il posto all'ombra, però, è bene ripeterlo, non nasconde il tumulto violento del mondo, non può e non vuole dimenticare l'orrore, che non smette di compulsare ai confini e fin dentro il cuore della stessa ombra. Se ne vanno i giorni / – scrive infatti Taormina – uno sopra l'altro / come giornali già letti / femminicidi guerre / odio razziale omofobia / la ruota del tempo gira / il mondo non cambia. Una nota di dolore e sconforto (il mondo non cambia) si stende su questi versi a incastonare l'offesa per un mondo che si ostina a ribadire la sua stupida ferocia. Allora il silenzio / cade nella stanza / come il ronzio di un insetto / sul tavolo verde / le carte del solitario / nascondono la sorte. Ancora l'immagine si blocca, ma quasi frizza, avvolta in un silenzio presago di accadimenti che rimangono irrisolti: quale sorte si svelerà al di sotto delle carte abbandonate sul tavolo? Come gli umani potranno ricominciare ad abitare il tempo, se il tempo appare davvero, ormai, un Giano bifronte, ora congelato in un eterno presente sempre più asfittico, ora precipitoso nella sua foga di dissipare ogni cosa, perché nulla varrebbe la pena di far durare e tutto è già inserito in un'obsolescenza programmata? Il tempo, il misurarsi con esso è, pertanto, uno dei fondamenti dell'arte poetica e un tema, in particolare, dell'opera tutta di Taormina. La sua scrittura, sempre con elegante soavità, è una tenzone con il tempo. Gentilissimo, titano della memoria, Taormina, dal suo posto all'ombra, non abdica alla vecchiezza – ribadisco nel senso simbolico individuato da Leopardi – non cede alla corsa all'impazzata delle ore, dei giorni, delle stagioni, degli anni. La consapevolezza dell'eterno ritorno dell'uguale, certo, è cogente: il vagone abbandonato / nel campo di girasoli / muore di nostalgia / i finestrini abbassati / cercano un respiro / i topi salgono e scendono / dagli sterpi senza attendere / le stazioni / un giornale abbandonato / su un sedile di legno / ingiallito è quasi illeggibile / le notizie sono uguali / a quelle di oggi “guerre / morti di mafia corruzione. Abbandono e disfatta sembrano aver avuto ragione. Solo il tempo non è sceso alla fermata. Il tempo consuma, dunque, divora. Lascia sul suo cammino macerie, frammenti. Se l'immobilità (curiosa immobilità perché, in effetti, lo scorrere del tempo insiste nel disfacimento) rapprende tutti i soggetti dell'immagine, l'unico a non fermarsi è – sorta di ironia tragica – il tempo. Esso continua la sua corsa, non è sceso alla fermata. È crudele kronos. Si precipita verso il nulla, perché potrà arrestarsi soltanto raggiunta l'estrema sparizione di ogni ente e del cosmo intero. Non ha pietà il tempo. Infierisce anche sugli adolescenti: nella porta aperta sul vicolo / – infatti – c'è una bambina morta / ha una rosa bianca tra i capelli / la fiamma di un lumino si storce. Se il vagone abbandonato del precedente componimento muore di nostalgia, si strugge, ancora, di un desiderio d'altri tempi che nemmeno l'andirivieni minaccioso dei topi può sopprimere, nei versi, che nella casa del lutto conducono, un alito spira ad animare la triste scena di morte e sei stelle (di nuovo le stelle) scese a curiosare / scivolano come meduse nella / ombra bagnata di lacrime. Con arguta invenzione le stelle – appena sei – non scendono dal cielo a partecipare, commosse, al lutto. Si abbassano però, aumentando, come nelle pitture di Caravaggio, la luce del fioco lumino interno alla stanza così da rendere più intensa e spettrale il particolare che emerge dal buio, e appaiono come sorprese dalla fragilità che contraddistingue la vita di questi enti umani. Meduse è la similitudine che caratterizza le stelle – paragone che da un lato riproduce il lento fluttuare nello spazio divenuto liquido e dall'altro richiama la gorgone, poi decollata, che con lo sguardo dava la morte – ma l'aria (l'aura?) in cui scivolano si eleva a metafora, è, infatti, l'ombra bagnata di lacrime. Ombra, sofferenza, rimembranza e nostalgia di un diverso possibile trovano in questo verso una straordinaria condensazione. Il tempo cancella non solo individui, ma anche intere epoche ricordavano Leopardi e Valery. Il tempo scava solchi profondi sui volti, testimonia la presente raccolta, per cui le rughe sono mandrie / che trasumano / tutto è diverso / è passato il tumulto / del tempo / gli zigomi sono estuari / di lacrime. In evidenza solitaria, campeggiano
nei versi, i termini tempo e lacrime. I valloni profondi, che il divenire incide, si riempiono però dello di un fiume – l'acqua è pur madre di vita – e l'estuario, lo sbocco finale, non ammette neppure l'approdo in definitivo ostello (i torrenti – continua la poesia dove la scelta del termine non può che richiamare l'insistente ribollire di un fuoco vitale – dopo tanto / scorrere di acque non so / se mi riporteranno a casa. Al rodere (come i topi?) del tempo, alla sua inesausta vocazione a scarnificare e ridurre in nonnulla, i versi di Taormina, nel loro umbratile magnetismo, oppongono sempre il baluginare di una irresistibile desiderio di un innamorato durare. L'arte promette a tutti noi che qualcosa si possa trattenere in questo momento – ha scritto Gadamer in Caducità. Questa tensione a trattenere, Taormina sa far palpitare, con levità, nei suoi versi, brevi e densi. Con le prime stelle / il quadro del paesaggio vacillava / sulla parete del tramonto, scrive il poeta. Non folgorazione, ma un sussulto, un empito muove questi versi e commuove l'anima del lettore. Si dà, comunque, ora lontano, ora talmente vicino da consentire il congiungersi delle mani un tu (femminile) che strappa, anche o forse proprio, nell'ombra ad una desolata solitudine. Le ricordanze e le attese non sono travolte dal tempo, lo punteggiano – come stelle nel cielo notturno – di pause vibranti. Anche una giacca dismessa e lisa, pertanto, può pulsare d'amore: Sulla spalla della vecchia giacca / – scrive Taormina – ho trovato briciole di baci. In poesia il linguaggio non è comunicazione, ma di certo è appello e istituzione della memoria. Sempre e comunque, anche nel descrivere tragedie, è promessa di afflato, sguardo oltre
ogni limitato orizzonte d'attesa. Occhi azzurri / mi guardano / dal folto / del canneto, scrive ancora il poeta. Qualcosa ci chiama, nascosto forse persino in una palude. Ci chiama a una vita più responsabile e sicuramente non immemore. Ci chiama a riprendere la battaglia con il tempo, a tendere la mano – pur nella consapevolezza della finitezza che contraddistingue gli umani – a una comunanza più ispirata. Vieni fuori / – dicono i restanti versi – getta il mantello / del tempo / prendi / la mia mano. Se ogni conoscenza è congedo – come diceva Gadamer – la pensosa e fine poesia di Taormina è anche preziosa nostalgia del ritorno.