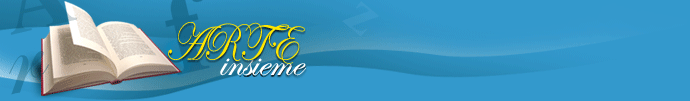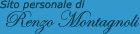Conversazione su Dante, di Osip Mandelstam, edito da Adelphi e recensito da Siti
Conversazione su Dante – Osip Mandelstam – Adelphi – Pagg. 116 – ISBN 9788845935657 – Euro 13,00
Recensione di Siti
Un
nuovo sguardo sulla Commedia in questo anno dantesco potrebbe far
piacere. Un anno in cui abbondano le pubblicazioni su Dante è più
pericoloso di tutti gli altri, anonimi , che hanno comunque già
fatto fiorire una delle bibliografie più consistenti del panorama
della critica letteraria. Allora, per non correre il rischio di
incappare in studi inutili, tediosi e perfino capziosi, è meglio
volgere lo sguardo indietro, verso la figura del poeta tra i
fondatori dell'acmeismo, quello stesso poeta che dopo
un'accoglienza promettente delle sue primissime raccolte di versi,
“Pietra”, “Tristia”, “Il rumore del tempo”, si vide
relegato ai margini del mondo intellettuale e poi estromesso del
tutto con la condanna per “attività controrivoluzionaria”,
morendo da deportato nel 1938, lontano dagli amici come Anna
Achmatova e dalla amata moglie Nadja Chazina.
Lo
sguardo di un poeta su un poeta è quanto di più illuminante ci
possa essere per il comune lettore. Si tratta di entrare in contatto
con una sensibilità unica che permette di leggere Dante ricordando
che egli fu il sommo poeta. Suono e discorso, intrecciati, in presa
diretta creano immagini fruibili solo al momento, la poesia non è
riproducibile e tanto meno parafrasabile. La poesia è suono, pura
fonetica, e l'italiano ha la capacità di riprodurre atavici suoni
dal carattere infantile che le imprimono così una sorta di
caratterizzazione quasi dadaista. Non solo, la poesia è materia, M.
attribuisce alla poesia di dante tutte le forme di energia note alla
scienza moderna: “l'unità di luce, suono e materia costituisce
la sua natura intrinseca”. Suggestivi i passi in cui l'autore
paragona la poesia di Dante al movimento, l'”Inferno” e il
“Purgatorio” che “celebrano la camminata umana, la misura e il
ritmo dei passi, il piede e la sua forma”, un movimento in cui
“anche la sosta è una varietà di movimento accumulato : la
piattaforma per una conversazione viene creata a prezzi di sforzi da
alpinista. Il piede metrico è inspirazione, ed espirazione è il
passo. Un passo che deduce, vigila, sillogizza.” Suggerisce
inoltre, se questo già non bastasse, una lettura dei versi danteschi
cercando di sforzarci a imparare a discernere al loro interno la
musica prodotta dai singoli strumenti. In questo modo legge per noi
il canto di Farinata aprendo la nostra mente ad altre suggestioni
circa il comportamento di Dante, sempre inadeguato e impacciato,
dentro il non luogo dell'inferno. O ancora, M. ritiene la D. C. un
poema costituito da un'unica strofa, unitaria e indivisibile, “una
figura cristallografica”, un poliedro a tredicimila facce,
mostruoso per la sua regolarità”. Si sofferma poi sulla
sovrapposizione stratigrafica della materia come tipico della
cristallografia, ci illumina sulla presenza del colore nell'inferno
e di come si possa allontanare l'idea che sia un poema a tinte
fosche. Le pagine poi sulla lettura del XXVI della prima cantica sono
bellissime, dense e complesse, stordiscono. Occorrerebbe citarle
perché ogni piccola frase nella sua estrema sintesi racchiude una
serie di sviluppi così che occorrerebbero delle pagine intere per
renderle perfettamente intellegibili. Eppure, seppur in superficie ne
cogliamo l'essenza. Come la poesia, le pagine di M. non si possono
parafrasare. Posso solo invitarvi a leggerle, mettendo bene in
evidenza che ho tralasciato di parlarvi di tanti altri spunti
contenuti in un libello che contiene appena un centinaio di pagine.