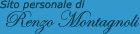Le vite degli altri, di massimolegnani
Le vite degli altri
di massimolegnani
Augusto Colonna aveva sempre svolto il proprio lavoro con professionalità e distacco: come perito del tribunale incaricato di preparare le aste giudiziarie, entrava nelle case sotto sequestro, osservava lo stato dei muri e degli arredi, annotava dettagli che potessero orientare il prezzo di partenza, faceva stime di massima, valutava gli oggetti rimasti se proporli in blocco o in lotti separati, e dopo qualche ora usciva, senza mai essere stato coinvolto dal vissuto degli ambienti. Lui era un tecnico, non un poeta.
Quel giorno gli era toccata la Eredi Giovanni Zuppi, una tenuta agricola in stato d'abbandono che comprendeva una risaia suddivisa in numerose camere dove ormai l'acqua ristagnava e vi crescevano solo erbacce, la casa padronale e una costruzione fatiscente dove un tempo alloggiavano le mondine a stagione. Nell'aia un vecchio trattore dalle ruote dentate era ricoperto di ruggine, altri macchinari agricoli erano sparsi all'aperto e non erano in condizioni migliori. Sembrava che la tenuta fosse stata abbandonata da un giorno all'altro in grande fretta senza il tempo di svuotare i campi dall'acqua e di riporre le attrezzature al coperto. Probabilmente, alla morte di Giovanni Zuppi, gli eredi, gente di città dedita agli affari, si erano disinteressati della tenuta e questa ora rientrava tra i beni coinvolti nel loro fallimento.
Augusto iniziò la perizia dalla villa padronale, la cui valutazione costituiva la parte più impegnativa di quella giornata: la struttura era solida e in discreto stato di conservazione, all'interno gli arredi erano ricchi ma piuttosto datati, difficile prevedere il loro impatto nell'asta, alle pareti erano ancora appesi alcuni quadri di autori piemontesi che nel Novecento avevano avuto una discreta risonanza a livello regionale. Il perito del tribunale annotò con il consueto scrupolo ogni dettaglio, quindi passò ad esaminare la costruzione in mattoni che a suo tempo aveva ospitato le mondine. Qui la visita fu rapida, c'era poco da valutare, cameroni su tre piani arredati di brande e comodini. Augusto si affacciò a una finestra per avere una vista d'insieme delle risaie. Fu colpito da un lembo di terra polverosa circondato dall'acqua e racchiuso da un muretto crollato in più punti. Controllò le mappe ma non trovò traccia dell'appezzamento, chiese allora al fattore che lo accompagnava di che si trattasse. Questi gli spiegò che era il piccolo cimitero sconsacrato dove un tempo venivano sepolte le mondine decedute sul lavoro, le cui famiglie lontane erano troppo povere per reclamare la salma. Augusto volle andare a vedere: uno stretto viottolo tra le risaie portava a quella piccola desolazione di terra abbandonata. Oltre un cancello divelto c'era il nulla, non una tomba riconoscibile, tantomeno una lapide, in un angolo erano buttate alcune rudimentali croci in legno dove qualcuno aveva annotato su pezzi di carta nomi ormai illeggibili. Ma che è successo? Cos'è questo scempio? chiese Augusto e il fattore raccontò che a un certo punto era intervenuta la sanità pubblica vietando ulteriori sepolture e provvedendo a traslare le salme presenti.
Augusto Colonna si guardò intorno smarrito e non osò chiedere dove fossero stati portati i miseri resti. Aveva sempre pensato alle mondine secondo lo stereotipo corrente di donne che mondavano il riso in schiere allegre e canterine. E invece no, queste donne morivano, decimate dalla malaria, dai reumatismi, dalla fatica, e di loro non rimaneva nemmeno la memoria di una tomba, il ricordo di un nome. Augusto fu preso da una smania di sapere, tornò di corsa ai cameroni come non ci fosse un attimo da perdere, rovistò nei cassetti, rovesciò i comodini, guardò sotto le brande, alla ricerca di qualche traccia. Trovò poche misere cose, un pettinino sdentato, una fascia per capelli, un orecchino di metallo arrugginito, un foglietto scritto a matita in uno stampatello incerto: ieri al ballo mi ha sussurrato Caterina, oh Caterina. E accanto alle parole c'era disegnato un cuore approssimativo.
Augusto si accasciò su una branda stringendo tra le dita il foglietto, lo rilesse più volte, finalmente aveva trovato un nome, una vita vera. Scosse la testa e mormorò: Caterina, oh Caterina, cosa sarà stato di te?
******
Augusto Colonna si era portato a casa dalla risaia quei poveri oggetti, il pettinino a cui mancava qualche dente, la fascia per capelli piena di polvere, l'orecchino di latta arrugginita, il foglietto sgualcito e, come fossero preziosi reperti archeologici, li aveva disposti con cura sulla scrivania. Ora li fissava nella speranza che gli evocassero una storia che non conosceva. Ma mancava la scintilla che lo facesse entrare nell'incanto.
Poi sentì una voce provenire da un'altra stanza come arrivasse da un'altra epoca.
Il muro lasciava passare suoni quasi indistinguibili, lui con una fatica disumana tendeva l'orecchio verso la parete, il timpano tirato come la pergamena sopra il bongo perché vibrasse solo alla frequenza esatta per udire quella voce che a tratti era soverchiata da brusii e rumori, provenienti forse da una radio dimenticata accesa.
Non sapeva a chi appartenesse la voce, probabilmente a una vicina di casa mai incrociata, ma ebbe la sensazione che il suo ascolto lo stesse introducendo in un'altra dimensione, la scintilla che aspettava.
Gli sembrò di decifrare una frase, Clara ti prendo la bicicletta, vado alla balera. Ma forse era tutt'altro, soprattutto l'ultima parola doveva averla aggiunta lui perché balere in città di sicuro non ce n'erano più. In ogni caso, una cadenza armonica, cantilenante, la voce un po' nasale, con l'inflessione dialettale di chi è costretto all'italiano per farsi intendere fuori dai suoi luoghi. Un'emigrante interna, quindi, diciamo dal Polesine fino a qui, nelle risaie del tempo andato, spinta dal bisogno. Sì, con l'ascolto e con la fantasia Augusto stava scivolando in un passato prossimo di anni magri, difficili, che in realtà non aveva vissuto.
Quel “Clara ti prendo la bicicletta” lo centellinò come vino da far rotolare rotondo in bocca. A ogni passaggio sulla lingua distingueva qualche elemento nuovo e lo gustava: non più di diciott'anni, e i più vissuti faticando; eppure “…vado alla balera” diceva, con un'intatta frenesia di vita. E i denti erano saldi, buono il loro smalto, che le parole rimbalzandovi acquistavano una sonorità particolare, un tintinnio aggiunto ad ogni sillaba, e poi quella specie di eco, merito forse di un palato alto, quasi ogivale. Era la risonanza mistica di una minima cattedrale gotica. La sua bocca.
Clara non aveva risposto, probabilmente era crollata nel sonno secco di una stanchezza disumana. Lei no, lei, la voce che intanto Augusto aveva battezzato Caterina, la Caterina del foglietto, lei, Caterina, avrebbe vinto la fatica accumulata nelle tante ore china a strappare erbacce per fare bello il riso.
Caterina, che avrebbe ballato scalza sul palchetto, già pedalava sullo stradone senza luna. Augusto, comodo in poltrona, la seguiva ingollando whisky con un'ostinazione ascetica fino a che fosse riuscito a vederla davvero pedalare. E ci riuscì.
L'orchestrina di campagna, tre suonatori pagati a fiaschi di rosso e a salumi di cascina, la fisarmonica, il violino, il clarinetto, una pena sentirli con l'orecchio di adesso, ma lui li immaginava allora, quasi perfetti al tempo del poco e del prezioso. Le stecche, gli sfiati, i cedimenti sarebbero scivolati via assieme alle note giuste. Era già tanto avere le due ore di musica e allegria. E lei, le zoccole un impiccio, le scarpe un sogno, volteggiava scalza sulla pista. Walzer, mazurche, i passi un pressappoco divertito, la gonna a balze a metà polpaccio, il sorriso sempre acceso, ormai Augusto lo conosceva bene il bianco dei suoi denti, e il cuore che libero bruciava tra le braccia di cavalieri dalla rozzezza mite e dai muscoli sinceri.
Ogni ballo un ragazzotto differente. Caterina tastava i bicipiti contratti sotto la camicia di flanella, sfiorava con la guancia le barbe ruvide e i baffetti accattivanti, scrutava occhi di brace e sguardi di promessa. Uno stordimento il ballo vorticoso, struggente quello lento. Non era il ballo, però, che la eccitava, ma l'idea del dopo, del forse e del chissà, che qualche volta lei finiva la serata tra la paglia del fienile, pretendendo e dando amore in egual misura.
Il ballo era il contatto con l'uomo, era la prova, il brivido, l'aspettativa, era il sentirsi donna al momento della scelta. Certe volte era uno sguardo in equilibrio tra spavalderia e rispetto a guidarla nella preferenza, altre volte un odore rassicurante di tabacco e di sudore, altre ancora era l'agilità imprevista di un corpo massiccio nei passi della polka, oppure il modo dolce e maschio con cui qualcuno, con un rammarico per il finire della musica, bisbigliava il suo nome, Caterina, oh, Caterina. E Caterina quelle parole sospirate dal ragazzotto le avrebbe trascritte in uno stampatello incerto sul foglietto che ora Augusto teneva delicatamente tra le dita.
Erano amori di una sera, piccole isole di terra strappata al mare o al riso, dove i loro corpi sarebbero morti in gemiti veloci, il buio e la musica lontana a far più bello l'attimo.
Comunque si fosse conclusa la serata, sul palchetto o nel fienile, Caterina, Il tempo di un saluto caldo ma privo di promesse, già stava pedalando sullo stradone senza luna.
Poche ore all'alba e poi sarebbe stata di nuovo la risaia.
Augusto, bevuto l'ultimo sorso, spense la fantasia come si spegne il televisore alla fine di un bel film. Ora di Caterina sapeva quello che c'era da sapere.