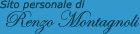Il paese ritrovato
Il paese ritrovato
di Renzo Montagnoli
Se passeggio lungo le strade del paese e magari mi fermo in una piazzetta è inevitabile che osservi i pur non sconosciuti edifici che la delimitano perché la mente corre a quelli che un tempo c'erano e che poi, per i piani regolatori e anche per le ingiurie degli anni trascorsi, sono stati rimpiazzati. Questo confronto è anche un esercizio di memoria, tanto più che è notorio che chi è avanti con gli anni tende più a ricordare il lontano passato che non il recente presente.
Oggi che è una bella giornata di sole, nonostante la stagione autunnale, voglio fare un salto dove era il nucleo antico, ormai da anni fagocitato da anonimi edifici.
Ecco, lì dove ora sorge una palazzina uso uffici c'era una costruzione a due piani ove risiedeva la Nure, la fruttivendola che ogni mattina scendeva le scale – abitava nell'appartamento di sopra – e disponeva in bella mostra la frutta e la verdura che Nini, il marito, alzatosi per tempo, aveva comprato al mercato all'ingrosso. Rammento gli accostamenti dei colori che facevano un bello sfoggio a seconda della stagione e all'abilità della Nure. In primavera i cestini di rosse fragole davano vita alle cassette di mele che già da troppo tempo avevano sopportato l'inevitabile declino dopo il raccolto di settembre e ottobre; la policromia si accentuava nell'estate, fra susine variopinte, albicocche arancioni e pesche rosate, insomma erano uno spettacolo per gli occhi prima ancora che per la bocca. I due non avevano figli, il lavoro con gli anni diventava sempre più gravoso e gli incassi invece scemavano per la concorrenza dei supermercati, così che un giorno – mi pare fosse ai primi di dicembre – trovai la serranda abbassata e un cartello con sopra scritto “vendesi”. Di lì a poco i coniugi si trasferirono in Riviera per addolcire la loro vecchiaia e da allora non so più niente, forse già sono nel mondo dei più per una questione puramente anagrafica, ma mi piace pensare che stiano a passeggiare in riva al mare a Sanremo o in altra analoga località.
Di fianco all'ortofrutta invece c'era la bottega del Memo, il calzolaio, tutto il giorno a ribattere chiodi e a risuolare; l'uomo era di poche parole, ma aveva una caratteristica e cioè gli piaceva cantare romanze d'opera con una bella voce tenorile e nel silenzio della piazza, dove ancora data l'epoca passano poche auto, era un piacere sentire il crescendo di Nessun dorma. I pochi passanti si fermavano ad ascoltare, lui smetteva di martellare, mancava solo la musica per sognare di essere alla Scala o all'Arena di Verona, e alla fine dell'esecuzione non poche volte c'era qualche applauso. Ci ha lasciati nel pieno della vita, un male subdolo lo ha strappato a chi gli voleva bene e gli ha impedito di salutarci con un ennesimo acuto.
Confinante con la bottega del calzolaio c'era un'osteria, sì avete capito bene, un'osteria, non un bar, disposta in modo tale che chi entrava trovava subito alla sua sinistra il banco delle mescite, il cosiddetto bancone, con gli inevitabili sottaceti e le uova sode, insomma il necessario per stimolare il bere. L'arredo era poi costituito da cinque o sei vecchi tavoli, che portavano come un marchio il cerchio del vino del bicchiere e che Parsut, l'oste, di tanto in tanto, puliva velocemente, passando uno straccio che non vedeva l'acqua da tempo immemorabile. Seduti ai tavoli, a ogni ora del giorno, c'erano i soliti, abitudinari, con il bicchiere davanti, a volte con i mazzi di carte (si giocava a briscola e a tressette), si parlava animatamente di calcio, animosamente di politica, e in fondo in fondo, nell'ultimo tavolo, c'era lo sprovveduto o scemo del paese, che ogni tanto alzava la voce senza che nessuno lo ascoltasse, oppure che veniva zittito in modo perentorio. Gente per lo più vecchia, pensionati che non sapevano come passare il tempo, stanchi di una vita in casa con una moglie magari come Santippe, un campionario di individui, che se non fosse stato per le differenze fisiche, sembravano tutti usciti dallo stesso stampo. Frequentavo poco l'ambiente e del resto al bar vado a prendere il caffè, e non il vino, e lì non è che non ci fosse la macchina del caffè, ma ci mancava poco che avesse le ragnatele. Usciti dall'osteria, pochi passi ed ecco la bottega di un artigiano, l'antro di un ciclope, che batteva ritmicamente il ferro arroventato. Era lì che lavorava il Guercio, che riscaldava il metallo, lo piegava per ottenere cancelli, inferriate, un lavoro che mi aveva sempre appassionato osservare, ma che mi sembrava più bello perché era lui a farlo, il mio eroe da ragazzo, la persona che stimavo di più da adulto. Mi sembra di vederlo che, accortosi della mia presenza, si girava e mi guardava con l'unico occhio buono, quasi un invito a fermarmi, per fare due chiacchiere, per raccontarmi qualcosa di quel paese di un tempo in cui non ero ancora nato. Parlava per cinque minuti e poi per altri cinque minuti riprendeva a martellare; ne aveva tante da raccontare e io ascoltavo come rapito. Così è stato per diversi anni, poi l'adorata moglie è morta, lui si è ammalato di cuore, è stato costretto a smettere di lavorare. Ci si incontrava però sempre lì, con lui che faceva sempre più fatica a parlare, che ansimava come il mantice della sua fucina e che ogni giorno che passava si spegneva come un lumino. Un giorno ha avuto una crisi, più forte delle altre, e non è riuscito a superarla. Al funerale pensavo che ci sarebbero stati in molti, visto quanto di buono lui aveva fatto per il paese, ma eravamo solo tre gatti. I tempi, soprattutto quelli attuali, non consentono di coltivare la memoria, si corre ogni giorno, pensando sempre al domani, non ci si accorge di vivere l'oggi e si dimentica subito ciò che è appena stato. Il Guercio riposa nel nostro piccolo cimitero, nella tomba di famiglia con la moglie e con la madre, all'ombra di una croce in ferro battuto, l'opera più bella, più intensa che aveva realizzato.
Nella piazza si trovavano un paio di abitazioni in cui vivevano delle famiglie di operai, con tanti bambini vocianti che giocavano sugli usci e spesso rimbrottati dalle madri che quando necessario ricorrevano alle maniere forti, e allora non era raro vedere uno dei pargoli raggiunto dall'autarchico drone dell'epoca, cioè la ciabatta.
C'era poi la casa del prete, staccata dalla chiesa (quella c'è ancora), un modesto edificio su due piani che aveva sempre ospitato i parroci del paese e in cui aveva vissuto e concluso la sua missione pastorale don Zeffirino, uno di quei preti che la chiesa non eleverà mai al rango di beati o di santi, ma che era vissuto in stato di grazia, proteso sempre a difendere i deboli, la versione in abito talare del Guercio. Lo ricordo poco, ero giovane quando è morto, ma quel poco e, soprattutto, quello che mi hanno detto in tanti, in primis il Guercio, mi ha fatto capire che doveva essere veramente un grand'uomo.
Ricordare mi stanca, comincio a patire l'età, così penso che sia opportuno che ora ritorni a casa e sospenda la mia ricerca di un tempo perduto che posso ritrovare solo nella mente.
Da Storie di paese