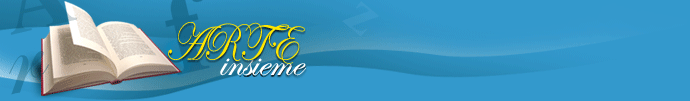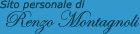Equilibrio, di Gabriele Oselini, edito da Fara e prefato da Fabrizio Azzali
Equilibrio – Gabriele Oselini – Fara – Pagg. 80 – ISBN 978-88-9293-055-1 – Euro 10,00
Prefazione
È nostro solo ciò che abbiamo perduto
… la neve / splende così ai nostri occhi fanciulli
(Attilio Bertolucci)
È il ricordare una facoltà vacillante, insidiata dal vuoto, affondata nell'abisso del tempo, la cui forma prima è l'oblio. Se riandiamo con la memoria agli anni lontani dell 'infanzia o della prima giovinezza, quei ricordi paiono scuotersi dal loro sonno greve e, come un nugolo di passeri sollevato da un fragore improvviso, si alzano in un volo caotico davanti a i nostri occhi per un momento poi si dissolvono. E, forse proprio per la sua natura volatile e fragile, quell'età giovane, caduta / come un passero ferito sull'erba fresca, mondata d'ogni incrostazione, al nostro sguardo diviene narrazione fantastica, giardino perduto del paradiso, in cui si vive come in un caldo sogno, per riprendere due versi di Bertolucci. Ma si tratta, in buona par te, di un' illusione ottica prodotta dalla distanza. Quello che ora ci appare come il tempo fatato, composto di colori e istanti mai più vissuti in seguito, la bella estate, è tale solo nella memoria dell'anziano. Come aveva compreso Pavese, a differenza di quel che si pensa, non è la fanciullezza l'età sognante bensì la vecchiaia. Il fanciullo è beniamino della vita, non sogna, abita un sogno; il vecchio è ormai soltanto un “viaggiatore incantato” e il suo viaggio, il suo navigare, si svolge il più delle volte a ritroso, verso le acque maternali. Nella nostra prima età infatti l'adesione all'esistenza e il godimento istintivo e alogico della realtà sono così intimamente fusi col nostro io infantile che tutto ci sfugge, non riusciamo a comprendere quel tempo, dunque paradossalmente lo abbiamo vissuto ma non lo abbiamo posseduto veramente. È come se volessimo vedere un quadro stando a un centimetro dalla tela: forse sentiremmo persino l'odore dei pigmenti, oltre a percepire un indistinto impasto di colori, ma l'opera ci resterebbe oscura. Dunque dobbiamo allontanarci per vedere e soltanto quando siamo così lontani da sentire i nostri sensi inutili, solo allora sappiamo di possedere realmente quella cosa, perché paradossalmente è nostro solo ciò che abbiamo perduto.
Non sembri strano che l'ultimo, intenso libro di poesia di Gabriele Oselini mi abbia suscitato tali considerazioni. Queste liriche, in cui tutto il superfluo è stato eliminato sino a un isolamento e una esaltazione della parola singola nei suoi valori di suono, di intensità emotiva e di significato, rappresentano infatti al primo sguardo un condensato taccuino di acquerelli dalla patina naturalistica, quasi nomenclatoria, composto di tanti quadretti dalle rapide velature impressionistiche. Il poeta lo porta con sé nel suo quotidiano vagabondare di signore di mezza età e vi ritrae una raffigurazione colorita, intima di ciò che vede, in cui l'autobiografismo è il tratto dominante, con gli affetti, i luoghi amati, le multiformi e vivide presenze campestri, le inquietudini del presente.
Il paesaggio evocato e che fa da sfondo a queste composizioni poetiche, ha poi il profilo dolce e familiare della pianura attraversata dal Po e dall'Oglio colto nel trascolorare delle stagioni e punteggiato di vecchi cascinali, boschi golenali e ordinate linee di pioppi, coi suoi lenti canali in cui si specchia la luna nelle notti chiare e che il merlo e il pettirosso o la rondine sfiorano col loro volo felice. Questo quello che ci restituiscono questi rapidi bozzetti: una quasi francescana adesione affettiva e sensoriale alla magia del creato e alle umili presenze che lo abitano.
Tuttavia, procedendo con la lettura e approfondendo, si ha la sensazione che la superficie della realtà riflessa in queste liriche s'increspi di un palpito che ne altera i contorni fisici: quei versi leggeri tendono a farsi sempre più lievi, quasi immateriali, i colori si diluiscono e il quadro pare ricomporsi in una dimensione ulteriore, metaforica, “doppia”, nel significato attribuito da Leopardi alla parola e per lui tratto peculiare dell'uomo sensibile: (… il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre, una campagna; udrà cogli orecchi un suono d'una campana; e nel tempo stesso coll' immaginazione vedrà un'altra torre, un'altra campagna, udrà un altro suono).
È come se Oselini, consapevolmente, abbandonasse la cartografia geograficamente delineata per inoltrarsi in uno spazio metafisico stabile e delimitato, dove ha luogo l'incontro tra presente e passato, dove l'esperienza del bambino che riposa nel profondo di noi stessi si fonde naturalmente con quella dell'adulto: giovane e vecchio insieme / sto nel recinto / di un nugolo di correnti. Sprazzi di luce antica si riaccendono all'improvviso e rischiarano i frammenti, teneri e scabri insieme, di quella sua età giovane e di quella società contadina al tramonto che ne era la culla, nonostante la forza corrosiva e distorcente del tempo.
E quella che ormai è divenuta, agli occhi grevi dell'adulto, dimensione dello spirito, riemerge in trasparenza in questi versi, talora col risalire dal “pozzo” di un volto caro e perduto, ma il più delle volte nel tratteggio dello scintillio di ricordi di momenti sospesi che sembrano rappresentare una sorta di inveramento di storie e di fiabe ascoltate: la discesa della neve bianca / lenta / afona, il verso dei grilli dal fondo dei campi, l'immobilità di una civetta o l'incantata comparsa delle lucciole, che nelle notti estive vincono il buio / per disegnare / mirabili costellazioni.
In quel paese remoto, e forse con maggior densità emotiva che nel presente, è possibile osservare / a occhi chiusi / il volo delle tortore, persino se le loro aeree traiettorie sono ormai da tanto concluse.
Quelle che sembrano rapide figurazioni di questo nostro tempo sono dunque inscindibili da visioni dipanate dalla trama sottile e intrigante dei ricordi e hanno la tenace morbidezza evocativa e simbolica di un antico sogno: spesso è proprio quella neve, quella civetta, quelle lucciole, quel volo di allora che gli occhi del poeta stanno fissando a palpebre chiuse.
Alla sostanza del reale si a ffianca un'intensa percezione interiore: nel bosco di noci / vociar di bimbi / come le avventure / del Fenilrosso / a rubar fragole / o le gare di nuoto / in Canalina / magia dell' infanzia / maifinita.
Ma questa proustiana risalita della corrente verso il diluvio del passato divenuto raggiungibile solo mediante una ricomposizione e interpretazione postuma, non serve in Oselini a constatare tristemente che il solco scavato dagli anni tra la felicità del tempo lontano e un presente smarrito è divenuto una voragine incolmabile e senza riscatto, come accade, ad esempio, per l'amaro approdo nichilistico de Le occasioni di Montale. Semmai ribadisce la convinzione che, lungi dal divenire spettro tormentoso o sterile rimpianto, ciò che è avvenuto spiega e restituisce significato al presente.
La costruzione del ricordo si pone infatti per Gabriele anche come condizione identitaria, come un argine alzato contro l'invasione del nulla, il recupero di una continuità organica e indivisa capace di ricomporre le lacerazione degli anni, di sanare la dicotomia esistente tra il tempo della vita e il tempo della rimembranza: non è mai una mera “cognizione del dolore”. Anche la nostalgia, che pur traspare in questi versi, non sembra essere, etimologicamente, “dolore del ritorno” o mesta rassegna di affetti feriti / prima del tuono, ma “luogo” in cui si costruisce conoscenza di sé, del senso del proprio fugace esistere, oltre che consapevole abbandono al gioco alterno e ineluttabile delle stagioni della vita: ci abbandoniamo mansueti / al presente / adagiati / su questo atomo / d'universo.
E l'infanzia “maifinita” dell'anziano torna così a scintillare col sorriso trattenuto e complice di un vecchio amico che ci fa visita e per un tratto di strada cammina al nostro fianco.
Parlando di William Blake, Ungaretti scriveva: “Il miracolo… è frutto, me l'aveva insegnato Mallarmé, di memoria. A furia di memoria si torna o ci si può illudere di tornare, innocenti”.
Dunque la natura più profonda della poesia, e forse della stessa esistenza, consiste probabilmente nel preservare sino in fondo la dimensione salvifica dell'immaginazione e nel custodire, anche attraverso l'arte, l'innocenza delle cose e dei ricordi oltre l'impervio spartiacque del tempo .
Fabrizio Azzali