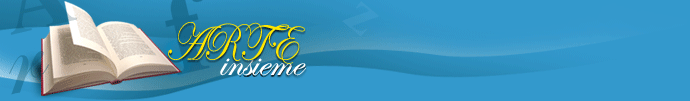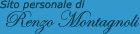Mus, di Barbara Sodi, edito da Rubettino e recensito da Fernanda Caprilli
Mus – Barbara Sodi – Rubettino – Pagg. 70 – ISBN 9788864921044 – Euro 12,00
Recensione di Fernanda Caprilli
Prima di entrare nel merito di questo piccolo pamphlet, che potrebbe essere considerato per certi aspetti anche una fiaba, vorrei fare una doverosa precisazione. Non sono un'animalista, ma amo gli animali; non sono vegana perché almeno una volta a settimana mangio carne, ma non mi convincono neppure le diete verdura e pesce perché sappiamo che anticrittogamici e microplastiche sono ormai il nostro pane quotidiano. Provengo da una cultura contadina che mi ha abituata a considerare gli animali come parte integrante dell'alimentazione ed è difficile per me uscire dal circolo vizioso innescato dal profitto, dall'inquinamento e dalla necessità di prodotti sempre disponibili in tutte le stagioni, tipico della società dei consumi. Ciò premesso, vediamo di capire chi è il personaggio di cui ci stiamo occupando: chi è Mus?
Il testo, nella sua struttura, potrebbe essere un apologo, oppure una fiaba, o ancora, come ho detto, un pamphlet.
In ogni caso Mus può essere considerato un testo di grande attualità perché mette a fuoco un tema centrale: quello della crudeltà contro gli animali che ancora oggi stenta a diventare consapevolezza e cambiamento.
Siamo nella stanza di un laboratorio: qui approda Mus, un giovane asinello che «aveva un manto verde pallido, una criniera rossa spruzzata di rosa sul collo e verde muschio sulla testa». Era nato diverso e proprio questa sua caratteristica gli aveva impedito di essere messo sul mercato e macellato, come era accaduto a sua madre. Di lei conservava una scatola di legno rossa, anche se proprio la mamma lo aveva pregato di non aprirla per non lasciare un varco ai sogni, né tantomeno mostrare ciò che sarebbe accaduto! Ma lui, di nascosto, l'aveva aperta e aveva visto se stesso «nel posto più bello del mondo».
Nel laboratorio c'erano bestie di varie specie, tra cui tre che portavano dei camici. C'erano un gatto, una pecora, ma piccola, un cane, una cagnolina, un coniglio e un animale arancione che non aveva mai visto, che seppe poi essere un orango, e dei quali conoscerà i nomi nel corso della prima triste conversazione (Otto, Pepè, Dun, Spina, Brin, Nelde ecc.).
Il capitolo III è uno dei più interessanti di tutto il racconto perché ci offre due punti di vista contrapposti: uno che si sviluppa dal testo e l'altro che nasce da una nostra considerazione. Infatti se è vero che la crudeltà cui sono sottoposti gli animali in questi laboratori è innegabile, l'Autrice avanza a mio avviso delle soluzioni alquanto inattuabili, per non dire utopistiche, che hanno comunque la forza di scuotere le coscienze. Gli ‘umani' che fanno sperimentazioni – dice il coniglio – «fanno test su di noi per trovare le medicine per malattie della razza umana […]». In sostanza: «Cercano di eliminare la sofferenza con altra sofferenza» ma è evidente che non ci riusciranno mai perché «Il dolore porta dolore, è una legge universale» e «Solo un'evoluzione verso l'alto, verso il bene», eliminando la scelta della tortura, potrebbe portare ad «eliminare le malattie». Soluzioni utopiche, possiamo dire, ma che fanno riflettere. Ma è proprio a questo punto che il lettore si pone una domanda: cosa sarebbe stata la storia della medicina (tanto per fare un esempio) se per secoli non si fosse proceduto su questa linea? La peste, la malaria, le polmoniti che uccidevano milioni di neonati come sarebbero state debellate senza l'utilizzo di una scienza empirica e poi di laboratorio? Credo proprio che il discorso di Barbara Sodi non voglia negare queste evidenze, ma piuttosto, attraverso la denuncia del dolore inferto agli animali, voglia mettere un punto fermo su ciò che è soprattutto da evitare: la crudeltà verso queste creature che, come noi, vivono su questa terra e avrebbero tutto il diritto di morire secondo natura, anche se purtroppo sappiamo bene che neppure l'uomo può essere esentato dalla sofferenza!
Il biologo marino Karsten Brensing, nel saggio: Cosa pensano gli animali? edito da Mondadori Retail nel 2020, nel capitolo intitolato Quello che mi lascia senza fiato, osserva: «I delfini si chiamano per nome e le orche vivono in un mondo antichissimo, di oltre 700.000 anni. Gli scimpanzé conducono battaglie strategiche e i bonobo adorano il dirty talk. Le megattere seguono le mode, i pesci sanno usare gli attrezzi e giocano con i termometri. Ai topi piace festeggiare e i corvi fanno snowboard sui tetti innevati.» Da qui la domanda che il ricercatore si pone: «Cosa significa in generale il fatto che nei test cognitivi gli animali riescano a operare distinzioni al pari degli uomini? […] Qual è il rapporto tra uomini e animali a questo riguardo?» La conclusione sarà in sostanza questa: tra uomini e animali esiste da questo punto di vista ben poca differenza!!
Questo apre le porte a una delle denunce più gravi delle sofferenze che questa nostra società impone a degli esseri senzienti. Se si eccettua la legge tedesca che obbliga gli allevatori a crescere i maiali in due metri quadrati prima che affrontino la morte, la situazione drammatica in cui si trovano tutti gli animali d'allevamento nella società dei consumi degli altri paesi è evidente e contraria a qualsiasi principio etico che dir si voglia! Ebbene, come afferma la neuroscienziata Lori Marino parlando dei maiali «Siamo in grado di dimostrare che i maiali condividono una serie di proprietà cognitive con altri animali altamente intelligenti come cani, scimpanzé, elefanti, delfini e persino noi umani». Come dire: abbiamo a che fare con esseri senzienti che come noi soffrono, capiscono, subiscono una ferocia che non ha limiti. È quanto si evince dai lunghi colloqui fra Mus e i suoi compagni di sventura a partire dal momento in cui questi propone di fuggire.
Si passa così dai ricordi sulla vita passata e sulla bellezza del mondo fuori da quel laboratorio al racconto del viaggio intrapreso da Mus verso la foresta, che è una pagina di poesia, perché è solo lì, nel silenzio, vicino a uno stagno che Mus intravede «una danza di luci pulsanti. Ogni luce – dice – mi parlava di un animale, di un albero, di una foglia, di un sasso, dicendomi che ogni cosa è viva e ha uno spirito». È a questo punto che Mus si fonde con «l'anima della natura» e sprofonda nella sua smisurata bellezza, mentre le lucciole lo avvolgono, sfiorandolo dolcemente, e dall'alto il cielo risplende di un blu cobalto tappezzato di stelle. Si fa strada così piano piano l'idea che sia possibile fuggire, anche se l'ipotesi di «diventare i personaggi di un sogno» pare a molti protagonisti inverosimile e poco credibile. Ma una volta che tutti hanno finito di raccontare i loro sogni assegnando loro un colore e ci si chiede dove possa essere cercato l'antidoto, Mus, dopo aver invitato Dun ad afferrare un'ampolla, scioglie il canto che le lucciole gli avevano sussurrato come una nenia: «Una goccia d'acqua è caduta / e l'universo ha vibrato / nella mia anima / Il tempo in stallo / la fronte sfiora / e le mie mani / toccano il nulla / Una sfera / che pulsa / cingono / inesistente all'occhio / viva al cuore / L'immateria cosciente / è qui / davanti a me / È come toccare l'amore.», un canto che segna il tempo dell'amore, sul dolore, sulla tristezza di tante povere creature. Dun, l'orango, capirà finalmente di aver trovato l'unica via di fuga possibile e piangerà di gioia.
Ci avviamo così verso l'epilogo. Con l'arrivo degli sperimentatori la fiducia di poter sfuggire alla tortura viene meno: «Hai visto Mus, sognare non serve a niente, niente, niente! – disse Spina con la voce spezzata. – Te e tutte le tue cazzate, l'antidoto, l'ampolla, l'amore, non salveranno Otto e Pepè!» Ma Mus è deciso a tentare la sorte e grazie alla scatola magica ottiene quello che solo nelle fiabe può accadere: la fuga degli umani e la via aperta ai suoi sventurati compagni dalla forza del sogno: «E sognarono così forte che spuntarono loro le ali».
Se il finale ricorda lo schema della fiaba, c'è però un punto di partenza su cui è importante soffermarsi: «Ma se per cambiare le cose dovessimo declinare veramente l'impossibile? – esclamò Pepè». È su questo punto che occorre soffermarsi per capire la forza del messaggio che Barbara Sodi ci propone. L'Autrice sa benissimo che siamo ancora lontani da una consapevolezza che porti gli uomini ad eliminare la crudeltà verso gli animali, ma ci invita comunque a fare ognuno la propria parte, elaborando una nuova visione culturale che coinvolga l'uomo e tutte le creature che popolano il creato fino ad accendere la luce «del dna cosmico, che unisce tutte le cose».
Come non pensare a quel Cantico delle Creature che apre la storia della nostra letteratura con un messaggio forte e inquietante per la coscienza moderna? Francesco che parla agli uccelli, Francesco che placa la ferocia del lupo e parla con tutti gli animali perché questi avvertono in lui la forza della compassione e della condivisione, è forse l'esempio più alto per affrontare un discorso che coinvolga tutte le creature e la creazione stessa indicando una strada oggi difficilmente percorribile, ma certamente unica, da seguire.
Arezzo, 27 settembre 2025