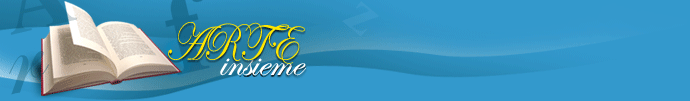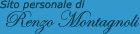Maestre d’amore. Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre, di Nadia Fusini, edito da Einaudi e recensito da Patrizia Fazzi
Maestre d'amore. Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre – Nadia Fusini – Einaudi – Pagg. 192 – ISBN 9788806247140 – Euro 19,00
Recensione di Patrizia Fazzi
S'intitola Maestre d'amore (Einaudi, 2023) il saggio di Nadia Fusini dedicato alle figure femminili nelle opere di Shakespeare. Già il titolo mette in evidenza il ruolo cruciale che le protagoniste delle storie sono in grado di svolgere. L'epiteto “maestra” al femminile è un notevole passo avanti, in quanto il maschile “maestro”, tuttora usato per rivolgersi a figure eccellenti dell'arte, musica, spettacolo, cinema, non sempre assume la stessa superiore valenza se usato al femminile e per di più assai raramente è usato per definire o rivolgersi ai grandi nomi della letteratura. Nadia Fusini invece con “maestre” denomina proprio le donne che si distinguono, per il “fine intelletto d'amore”, dai rispettivi partner, ai quali esse insegnano i principi fondanti della relazione amorosa, li ‘educano' ad un rapporto paritario.
L'altro termine del titolo - amore – è al centro di ogni opera analizzata, sia tragica che comica, ma non si tratta più dell'amor cortese di medievale memoria, in cui la dama era ossequiata, vagheggiata dal fin amant ma rimaneva per lui un traguardo irraggiungibile. Quello che le innamorate shakespeariane inseguono e vogliono – liberamente, come atto di voluntas e non solo voluptas - è un amore reale, di godimento e visione dell'altro e mira ad una congiunzione suggellata dal matrimonio (La catastrofe è nuziale” s'intitola in capitolo del libro). Così è per Giulietta, che si concede a Romeo come a uno sposo e i due si sposano in segreto, così è per Elena in Tutto è bene quel che finisce bene, in cui la giovane non si risparmia in nulla pur di conquistare l'amato, che pare respingerla e anche lei, come in altre storie, ricorre ad uno stratagemma, come un cambio di persona, una beffa o travestimento, che sortisce un buon effetto finale.
Sono queste ed altre quelle che Nadia Fusini, docente universitaria e finissima studiosa di Shakespeare, definisce, con termine inglese, eroine del selfwill e del freewill e di cui il libro fornisce una esauriente galleria, partendo da quelle delle opere tragiche (Giulietta, Desdemona, Cleopatra) per poi passare a quelle delle commedie: Ermia e Elena in Sogno di una notte di mezza estate, Elena di Tutto è bene quel che finisce bene, Caterina in La bisbetica domata, Beatrice in Molto rumore per nulla, Rosalinda in Come vi piace, Viola in La dodicesima notte, Isabella in Misura per misura e la principessa di Francia in Pene d'amor perdute. Shakespeare crede nella libertà di scelta della donna, in una nuova generazione di eroine che lottano per liberarsi da schemi ancestrali e raggiungere il loro obiettivo amoroso. Uno Shakespeare “femminista ante litteram?” si chiede la Fusini. Forse no, ma certamente una forte apertura ad un nuovo “modo di concepire l'amore fra i sessi”, in cui “un uomo e una donna dovevano addivenire a patti diversi nel dichiararsi soggetti attivi del verbo amare e del verbo piacere “(pag. 131).
Leggere questo libro significa entrare a fondo nell'opera shakespiriana, comprendendo con quanto ingegno e creatività, pur attingendo alla storia vera (Antonio e Cleopatra), ai classici latini Apuleio, Ovidio…), a novelle (Decameron di Boccaccio), leggende o folklore, il geniale bardo di Stratford on Avon sia riuscito a rielaborare e rinnovare tutta la materia narrativa e i luoghi - a volte inventati - mirando a delineare un concetto nuovo di relazione amorosa tra uomo e donna, un rapporto in cui la donna sia soggetto attivo di desiderio amoroso e non oggetto passivo, che in questo caso diviene l'uomo che la protagonista desidera portare al matrimonio.
Una concezione più in linea con i tempi in cui Shakespeare vive - la puritana età elisabettiana post-riforma che promuoveva le nozze per contrastare gli amori clandestini - ma al tempo stesso che svela le ipocrisie, i limiti, le contraddizioni dell'imperante puritanesimo, dei quali è emblema la regina Elisabetta che, pur avendo diverse relazioni, non si sposò mai. E lo fece, sottolinea l'Autrice, “perché non voleva un Re sopra di sé. Sapeva bene che sposandosi sarebbe stato lui il suo Signore, lui the king, lei the Queen…” (pag. 79).
Altro pregio assoluto del libro è il ricorso ad un linguaggio colto, criticamente perfetto e al tempo stesso scorrevole, chiaro, coinvolgente, capace di rivolgersi direttamente al lettore, oltre ad una scrittura ricca di citazioni e termini non solo inglesi, ma francesi, latini, greci, germanici, andando alla scoperta di etimologie linguistiche, riferimenti letterari e sociali. Ogni termine è non solo spiegato nelle sue origini ed uso ma anche oggetto di una riflessione sui doppi sensi, sulle assonanze, sulle mutazioni e rapporti con l'uso antico e corrente, così che il lettore è stimolato ad un continuo gioco lessicale, scaturito proprio dall'uso sapiente e ironico di nomi e termini messo in atto dall'autrice.
Ogni capitolo è suddiviso in paragrafi dai titoli esemplificativi, curiosi a volte, ma che approfondiscono i vari aspetti della vicenda e dei personaggi, conducendo il lettore nel vivo della società del ‘500 ed insieme aprendo un varco prezioso su quelle successive. Dirò di più. Dopo aver letto Maestre d'amore, si potrà comprendere meglio le opere messe in scena teatralmente e verrà voglia di andare a cercare i testi originali di Shakespeare e ripercorrerli con una visione più chiara.