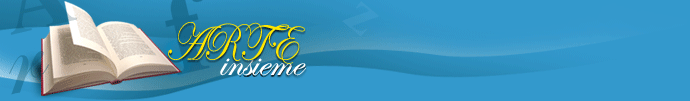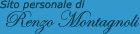La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860 – 1870, di Carmine Pinto, edito da Laterza
La guerra per il Mezzogiorno.
Italiani, borbonici e briganti 1860 – 1870
di Carmine Pinto
Laterza Editori
Storia
Pagg. XIV-496
ISBN 9788858135310
Prezzo Euro 28,00
I briganti, eroi o delinquenti?
Il movimento neo borbonico favoleggia di un meridione che prima dell'Unità era prospero, definisce il brigantaggio dopo la sua annessione all'Italia come un forte movimento di resistenza all'oppressore sabaudo che impoverì quelle terre depredandole di continuo. C'è da dire peraltro che a supporto di queste tesi nulla viene portato che non sia la semplice chiacchiera, dimenticando che per scardinare una storia ormai acquisita non bastano di sicuro le parole, ma occorrono fatti e documenti.
Carmine Pinto con questo suo interessante saggio ha voluto vederci chiaro, ricorrendo, argomento per argomento, a un'ampia documentazione storica e archivistica, con cui sono contestate le teorie dei neo borbonici.
Se l'avanzata di Garibaldi, dopo il suo sbarco in Sicilia, proseguì trionfalmente con la partecipazione di migliaia di meridionali e se poi avvenne, dopo Teano con l'incontro dell'Eroe dei due mondi con Vittorio Emanuele II, l'annessione di quello che era il Regno delle Due Sicilie al nuovo Regno d'Italia, è indubitabile che in seguito ci fu un tentativo di restaurazione, promosso dall'ex re Francesco II e dallo Stato della Chiesa, tentativo che anziché essere affidato a un esercito regolare si estrinsecò in azioni di guerriglia al cui avvio diedero impulso i briganti già esistenti, ai quali poi se ne aggregarono altri.
Pinto sfata subito il mito del brigantaggio meridionale come emblema della libertà e della ribellione contro gli invasori piemontesi; lì non c'erano certamente dei Robin Hood o dei Che Guevara, lì c'erano fior di mascalzoni che si videro legittimati a rubare, devastare e opporsi all'esercito regolare piemontese, nonché alla Guardia Nazionale, composta esclusivamente da elementi locali.
Non esisteva un piano articolato, semplicemente si voleva rendere difficile e pericoloso il governo dello stato italiano, creare uno stato di tensione e confusione tale da provocare un'insurrezione popolare, che però non accadde.
I briganti vivevano sulla popolazione, la taglieggiavano, in genere erano estremamente violenti, insomma se viene data a dei delinquenti la licenza di uccidere sono sicuri i tragici risultati. Ma se agli inizi questi ribelli poterono contare su un certo appoggio delle genti del meridione (però più per paura che per convinzione), mano a mano che la sorte dei briganti appariva segnata, agli stessi venne meno quel sostegno popolare indispensabile per operare; il risultato fu che più o meno dal 1864 furono costretti a combattere per sopravvivere, pressati da ogni parte. Si dovrà però arrivare al 1870 con la cattura e l'uccisione degli ultimi capi importanti perché il fenomeno perdesse di rilevanza, limitandosi in seguito a poche bande che poco a poco si dispersero.
Fu una guerra sanguinosa e crudele, perché all'iniziale ferocia dei briganti, le truppe regolari e la Guardia Nazionale risposero colpo su colpo.
Pinto rileva anche che accanto all'aspetto militare ci fu quello politico, visto che il Parlamento italiano fu luogo di accesi dibattiti in ordine ai metodi per la soluzione del problema; in buona sostanza vinsero due azioni congiunte, e cioè l'integrazione del meridione nel nuovo stato e l'azione militare priva di incertezze, a sua volta condotta secondo metodi di guerriglia, con il ricorso anche di reparti speciali appositamente addestrati.
Per concludere, smontando tante teorie strampalate uscite dalla fantasia dei neo borbonici, secondo Pinto la guerra dei briganti è stata caratterizzata dalla quasi completa assenza di distinzione tra scopi criminali, scopi privati e motivazioni politiche, insomma il brigante visto come uomo senza paura che combatte per il suo popolo è una visione popolare del tutto irrealistica.
Da leggere senz'altro.
Carmine
Pinto insegna
Storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Salerno.
Ha scritto sui sistemi politici del Novecento e si occupa di guerre,
conflitti civili e movimenti nazionali nel XIX secolo. Per Laterza è
autore di Il
brigante e il generale. La guerra di Carmine Crocco e Emilio
Pallavicini di Priola (2022).
La
guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti
1860-1870 ha
vinto, tra gli altri, il Premio Cherasco Storia, il Premio Sissco, il
Premio Fiuggi Storia e il Premio Basilicata.
Renzo Montagnoli