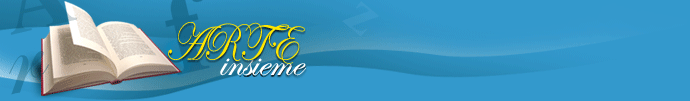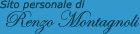Senza gravità, di Marilina Giaquinta - Samuele Editore
Senza gravità
di Marilina Giaquinta
Samuele Editore
Poesia
Pagg. 186
ISBN 979-12-81825-30-7
Prezzo Euro 15,00
Versione online Sbac! Prezzo Euro 7,00
La vita è un gioco, senza garanzia di fondamenti rassicuranti, ma in grado comunque di dare forma, come la “forma sferica” che tanto riesce evocativa e simbolica – “pensate alle romantiche gocce di pioggia” –, pur non essendo riferibile che “alla tensione superficiale: / e cioè all'insieme di forze interne / tese a trovare lo stato / di minima energia possibile”. Ma l'ordine giocoso della vita, e che le leggi di natura ci ricordano, è lo stesso che intesse i rapporti d'amore, finalmente intesi al di fuori di ogni atmosfera e ideologia sentimentale. Amore è riportato qui, nel lavoro poetico, a un pathos fondamentale che è anche un patto con la natura. Da questo punto di vista è senz'altro utile ricordare una delle più riuscite metafore della raccolta, che coniuga un rapporto emblematico tra l'umano abbraccio amoroso e l'avanzare nel buio della talpa stellata. Il piccolo mammifero, che nel corso dei suoi tentativi evolutivi ha sviluppato sul muso una stella formata di innumerevoli tentacoli – analoghi alla innervazione sensoriale delle nostre mani – permette alla poetessa questa bella metafora: “Per questo dovremmo usare le mani / per vederci dovremo chiudere / gli occhi per cercarci dovremo / usare il buio per scorgerci / dentro le nostre braccia stellate”.
L'amore
non è per nulla qui circoscritto all'ordine del rapporto
sentimentale, ma si correla a una originaria relazione con l'altro.
Ma se è questa relazione a innervare la poesia, al tempo stesso la
poesia non può non porsi che a difesa di essa.
Qui si scopre il
passaggio etico, e più impegnato, del libro, venendo in luce
un'etica dell'“estrema e disperata resistenza” rispetto
all'epoca
della povertà.
La parola che eccede per definizione non può non antagonizzare –
“con
la poesia si possono cambiare le cose modificare / il modo di
pensare”
– quell'inferno dell'uguale che siamo diventati: “pregiudizi
che cerchiamo dove ci fa comodo”,
“vuoto
e accomodante conformismo”,
“finto
buonismo”
oltre che “certa
tautologica verbosità politica”.
In
breve, il nostro tempo – “questo
tempo / che sto vivendo non mi piace”
– è caratterizzato dall'oblio della negatività ossia
di quella mancanza necessaria al costituirsi delle differenze e che
le espone in tensione dinamica tra loro. Senza il “dubbio”
e il “conflitto”
non c'è – dice, anzi grida la poetessa: “voglio
dirlo urlarlo pubblicarlo”
– relazione. Il “conflitto”
però nulla ha a che fare con la aggressività gratuita o “l'odio”,
non essendo “che
la consapevolezza del nostro limite / per imparare a ricondurre
dentro di noi / l'altro”.
L'altro a rigore “non
esiste se non lo riconosciamo”;
e a rigore di poesia: “se
non esiste allora finisce che lo mettiamo di / nuovo dentro i lager!”
A
una poesia tanto ispirata dalle “pene
della mancanza”
ossia dal pathos per
la vita che la stessa scienza ci insegna – “siamo
sistemi complessi processi discontinui anche se ci raccontiamo
unitari”
–, una dimensione di “profezia
buona”
è sempre possibile. In altri termini un “feroce
bisogno d'amare”
torna ad affermarsi, proprio mentre un senso di rispetto/giustizia
viene affidato a parole di ammonimento che sembrano scritte per
essere mandate a memoria: “Miserabile
è chi crede di / vivere senza rendere il conto / che crede che
niente costi e si paghi canaglieria a / buon mercato […] a
nessuno è permesso il male / nessuno racconta e ottiene. /
L'impostura è piena di tormento”.
Poetessa
impegnata e sperimentale più che antilirica, siciliana nella “grana
della voce”, oltre che nelle formule lessicali e nell'ethos
isolano dichiarato, la Giaquinta non può che colpire, con questa
silloge, per l'autenticità della voce mai autoriferita e
invece aperta e
senza riparo.
Marco Marangoni
Scriveva
Newton
che le comete lontane
“si attirano mutuamente
in
misura minima”
ma si attirano
anche se poste a
una
“distanza immensa fra di loro”.
Tuttavia
la forza di gravità
attrae a sé ma non allontana
non ci
riesce e non lo sa fare.
E così è il ricordo
(è
una forza che attrae
e non sa e non può allontanare)
anche
se somiglia
a un vortice cartesiano
immerso in un cielo
fluido
particelle di memoria
“in un grandissimo
numero”
che nel caos della mancanza
girano intorno al
proprio centro
e tutte insieme attorno al punto
che le
unisce tutte
che è l'ombra del tempo.
Sono
stati giorni facili
abbiamo riempito il tempo
(qualcosa che
scorreva
e che sembrava sottrarci
senza la nostra
opposizione)
con tutto quello che avevamo
disponibile a
portata di mano
e che non avevamo ancora usato
un'inaugurazione
di buoni propositi
senza però l'impegno del pensiero
e
sopratutto della parola forte
con l'urgenza buona del
silenzio
quando la vita diventa un ordine
che non si può
non eseguire
incapaci di trovare un'altra ipotesi.
Abbiamo
lasciato andare
tutto quello che avevamo conservato
dentro
il vuoto della mancanza
che a sentirlo sembrava caldo e
pieno
come il campo di Higgs dell'Universo
una mancanza
qualsiasi
una di quelle che ci vogliono
molti e
perseveranti tentativi
per arrivare a provarla e ad agirla
a
distinguerla in mezzo a tutte le cose
che confondono e che non
guariscono
la privazione che la vita si prende
senza mai
restituire neanche i resti
senza concedere prescrizione
o
garanzia per evizione ai nostri errori.
In
fisica si chiama “anisotropia”.
Questa lingua di
scienza
crea parole crudeli
con la scusa del greco
e
incute il timore
della stessa comprensione.
Eppure il
significato è semplice.
Una grandezza si dice anisotropa
quando
il suo valore
dipende dalla direzione considerata
e quindi
ha valori diversi
nelle diverse direzioni spaziali.
Studiando
gli stormi
degli storni che annerano
il cielo di Roma
coi
loro dischi volanti
il nostro Premio Nobel
ha verificato
che l'anisotropia
diminuisce con la distanza.
Fin qui
niente di nuovo:
la fisica è abituata
a interazioni
che
dipendono dalla distanza.
Tuttavia – si sa – i
Premi Nobel
sono testardi nella ricerca
e osserva che ti
osserva
si è accorto che l'interazione
è sempre con i
più vicini
e che l'interazione non dipende
dalla
distanza assoluta delle coppie
ma dai rapporti relativi delle
distanze.
Forse adesso è chiaro
perché ho scomodato un
Premio Nobel
che studia i sistemi complessi
per parlare
d'amore?
(e d'altronde dove lo trovi
un sistema più
complesso dell'amore?)
Anche noi ci regoliamo
– come il
volo degli storni –
sulla posizione dei vicini
ed è per
questo che stare lontani
ci fa perdere la rotta
ci fa
sbandare ci fa sbattere
e cadiamo in caduta libera
nel
vuoto senza cielo
alla faccia della costante di
gravità
qualunque sia la massa o il peso
dell'amore che
ci sostiene.