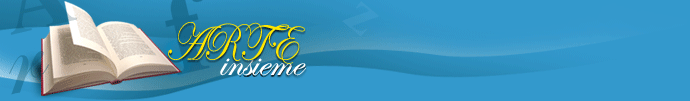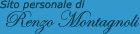Io non aspetto, di Adriano Gennari e Federica Niola, edito da ExCogita e recensito da Alberto Carollo
Adriano Gennari, Federica Niola, Io non aspetto, (ExCogita Editore, 2009, pp.150, € 12,50)
Inusuale e intrigante, il libro
d'esordio di Gennari e Niola
si impone al lettore per almeno due peculiarità che spiccano su altri temi o
aspetti: quello di essere prima di tutto un work in progress e in seconda battuta
una ricognizione appassionata sulla pratica della scrittura.
Gli autori sono due professori di liceo che, soffocati dalle spire della
burocrazia scolastica, decidono di creare un'oasi, un'area protetta dove
baloccarsi con un nuovo gioco: la costruzione di alcuni personaggi e la
composizione di un intreccio.
Il romanzo prende forma e si dipana su un doppio binario. La cornice, che è poi
parte integrante di tutto il lavoro, vede gli alter ego dei due prof, Giordano
e Gaspara, scambiarsi i fogli e commentare
vicendevolmente i propri esercizi di scrittura, tra un collegio docenti, un'ora
di lezione e un passaggio in sala insegnanti. L'intesa fra i due si rinsalda
man mano che il manoscritto si trasforma in un consistente malloppo di pagine;
e quella che all'inizio sembrava una scommessa diviene col tempo un impegno
costante e irrinunciabile, dal quale attingere nuovi stimoli e linfa vitale
nella bieca routine di ogni giorno, un rifugio segreto dove cospirare contro le
mortifere assemblee e il loro vuoto chiacchiericcio, contro i colleghi sviliti e
demotivati, detentori di un sapere che somministrano in stanchi e ripetitivi
rituali. Non mancano infatti, en passant,
tra siparietti più o meno grotteschi, vere e proprie bordate all'odierno
sistema scolastico: “La scuola degli anni 2000 è un posto lungo come un'ombra
estiva la sera. I professori sono sagome vaganti intristite dal tempo che vanno
ripetendosi che i ragazzi d'oggi non capiscono niente, che sono privi di
ideali, che pensano solo a drogarsi e a telefonare in una sorta di isteria
collettiva (...)”
Nel duetto è Giordano quello che appare più convinto e
determinato, che sprona Gaspara, dubbiosa e
recalcitrante: “La intercettò e le chiese che cosa ne pensasse, lei, del fatto
che scrivere a quattro mani non fosse esattamente come scrivere a due. Gaspara gli rispose che, semplicemente, non lo sapeva
perché non aveva mai scritto, ma solo letto in tutta la sua vita.” Non ci vorrà molto perché la scrittrice in erba subisca
per intero la fascinazione del compito che la attende: “Quanta fatica e quanta
passione ci vuole anche solo per mettere sul foglio una frase che non sia una
semplice informazione da dare.” I due sembrano amoreggiare tra loro per mezzo
delle parole; i dialoghi sono farciti di sottile ironia e doppi sensi. La
storia che decidono di raccontare è geometricamente confinata all'interno di un
quadrilatero amoroso. Quantitativamente, occupa maggior spazio nel testo la
storia di Marco e Marta. “Con Marta tutto era successo con
naturalezza. Lei non aveva distolto lo sguardo, quando le aveva detto,
così, pari pari, che voleva
fare l'amore, che le avrebbe messo le mani dappertutto.” Si tratta di una
relazione extraconiugale – topos frequentato nella vita come in tanta narrativa e
filmografia – tra due persone di estrazione borghese, che nell'anodina provincia
veneta fin qui hanno condotto esistenze ordinarie, segnate dal consueto ménage
di coppia. Non ci troviamo, però, di fronte a un corrispettivo riveduto e
aggiornato di Signore
e signori. L'adulterio non è vissuto con l'uzzolo godereccio e
scanzonato di chi coglie al volo l'occasione, 'ché
ogni lasciata è persa. In Io non aspetto l'inquietudine
esistenziale la fa da padrona, la noia moraviana
ammorba l'anima: “(...) potremmo raccontare la storia di quattro giovani
adulti che per tutta la vita non hanno fatto altro che rimandare qualcosa che
sapevano di dover fare.” Gli altri due lati della nostra figura sono
occupati da Lina e Flavio, rispettivamente la moglie di Marco e il marito di
Marta. Al termine di una “notte brava” rincaseranno tutti e quattro, ognuno per
proprio conto e, fatta la doccia, rifluiranno nel corso delle loro vite
omologate, nel torpore di giornate sempre uguali, come dei profughi da un
doppio sogno di schnitzleriana memoria. O forse no;
in qualcuno quanto è accaduto ha lasciato un segno profondo, almeno in un caso,
quello di Marta. Dei quattro personaggi creati da Gaspara
e Giordano, Marta è il carattere più sfaccettato. Sorta di cellula dormiente di
una schiera di potenziali erotomani, Marta vive fino a un certo punto
nell'alveo rassicurante che il matrimonio con Flavio le ha riservato: il ruolo
della moglie passiva, immalinconita, scontenta della sua relazione, incapace di comunicare il proprio disagio al marito distratto.
Marco è l'elemento scatenante, il detonatore che fa deflagrare una sensualità
per troppo tempo repressa, fermamente decisa a cogliere l'attimo, a
riguadagnare il tempo perduto. A saltare nel vuoto. Marta è il grimaldello che
Giordano e Gaspara vanno cercando per forzare le
resistenze di una vicenda che alla fine si vorrà scrivere da sé. Ai due non
resterà che mettersi al servizio della storia che hanno sin qui imbastito. E'
proprio nel momento preciso in cui Marta intraprende il suo viaggio nell'ignoto
che la cornice si rende inestricabile dal racconto che si è prefissa di
generare. I confini del romanzo nel romanzo si fanno più labili. Un congegno
come Io non aspetto, in altri termini, rimane pericolosamente in
bilico sul precipizio. I suoi punti deboli sono lampanti nella disomogeneità
del dettato, che distingue nettamente le due voci, riconducendole a precise
identità autoriali, col loro personale bagaglio
(com'è giusto che sia, del resto); nell'intreccio, piuttosto convenzionale e
nella quantità non indifferente di scene di sesso che sono altrettante forche
caudine per gli scrittori. Come a dire: Gennari e Niola osano, e a un passo dal dirupo le debolezze si
rivelano essere dei punti di forza che puntellano e mantengono in equilibrio
l'intera struttura. Le carte sono scoperte fin dal principio: scrivere è vivere
esistenze parallele, sbrigliare il proprio immaginario, anche erotico. Così
l'ordito, abbandonata qualche lungaggine iniziale, si adatta con gradualità
all'evoluzione psicologica dei personaggi. Se la scrittura di Gennari appare più sicura fin dal principio, sobria e
diretta nel perseguire gli obiettivi che la performance richiede, quella di Niola tentenna nella gabbia di un'impostazione classica,
forte di tante letture e competenza, apprezzabile ma meno aderente alle
esigenze del quartetto di personaggi e ai loro intrallazzi. La
consapevolezza, comunque, non difetta, e così anche il cambio di rotta che
mantiene genuino il carattere in fieri del romanzo che si va delineando: “Sto
pensando a come dovrei scrivere per essere meno pletorica. (…) Mi accorgo che talvolta mi lascio prendere la mano e che
mi soffermo sulle parole. Mi sembra quasi di perdere la visione dell'insieme e
di indugiare sulle subordinate, restando io subordinata alla sintassi.” Così, se nei primi capitoli una certa reticenza fa
indugiare Gaspara nell'invenzione compiaciuta di
allusioni e curiose metafore, man mano che il “termometro sessuale” della
narrazione sale, la prosa si affila, circoscrive degnamente il suo oggetto,
diventa più esplicita e icastica. Di particolare rilievo, anche visivo,
l'episodio della fuga di Marco e Marta nella laguna veneziana, a mangiare il
pesce nel ristorantino di un paese sperduto, dove i due autori ricreano
sapientemente l'atmosfera fumosa e dozzinale, i profumi della cucina, gli
sguardi famelici che si scambiano i due innamorati e gli umori delle loro
bocche; e il party di Vladimir, generoso ancorché grato anfitrione, con tanto
di orchestra dei Balcani e uno spicchio di mondo gitano e multicolore, dove
Marta giocherà con Marco la partita finale della trasgressione estrema. Per
votarsi, forse, a una perdita definitiva di sé. Il racconto che era iniziato
quasi per caso, ha invocato un possibile svolgimento e un altrettanto
plausibile epilogo. Gaspara era sopraffatta
dall'urgenza di quanto la penna voleva far uscire sulla carta ma Giordano l'ha
esortata a non aver paura, a far dire al suo personaggio quello che lui direbbe
a se stesso senza remore, senza schermi. La scommessa, non senza fatica, è
stata vinta, e una tale dichiarazione d'intenti potrebbe da sola, semplicemente,
costituire un pilastro etico della pratica narrativa. “Benvenuta
nel club degli ostaggi della parola. Non ti ci è voluto molto per
contagiarti, vero?”
Adriano Gennari è nato a Rossano Veneto nel 1959 e
vive a Vicenza, dove insegna Storia e Filosofia in un Liceo della città.
Federica Niola è nata a Vicenza nel 1960. Lavora in un Liceo cittadino, dove insegna Lettere.
Alberto Carollo